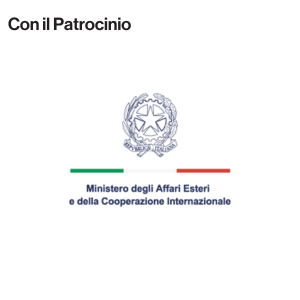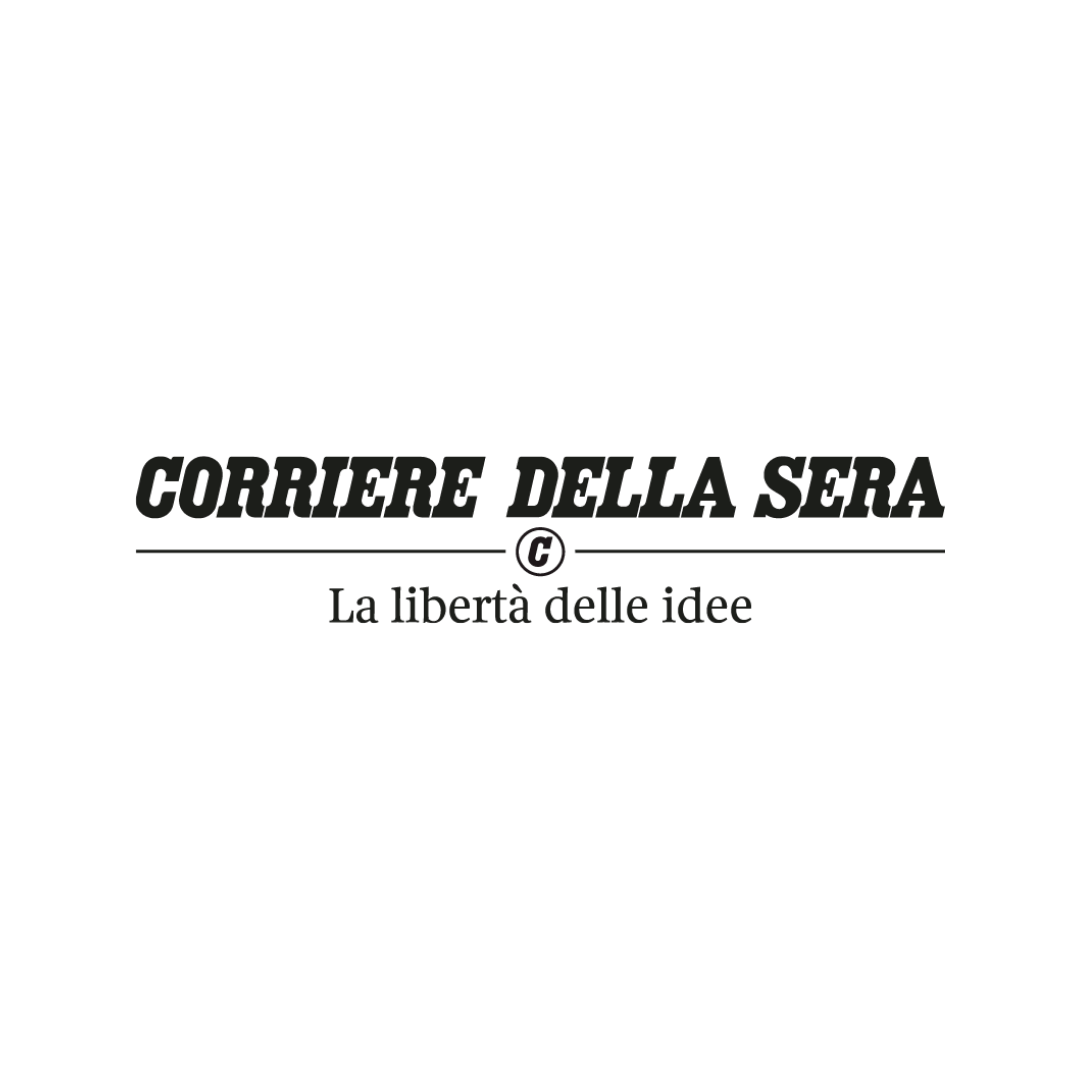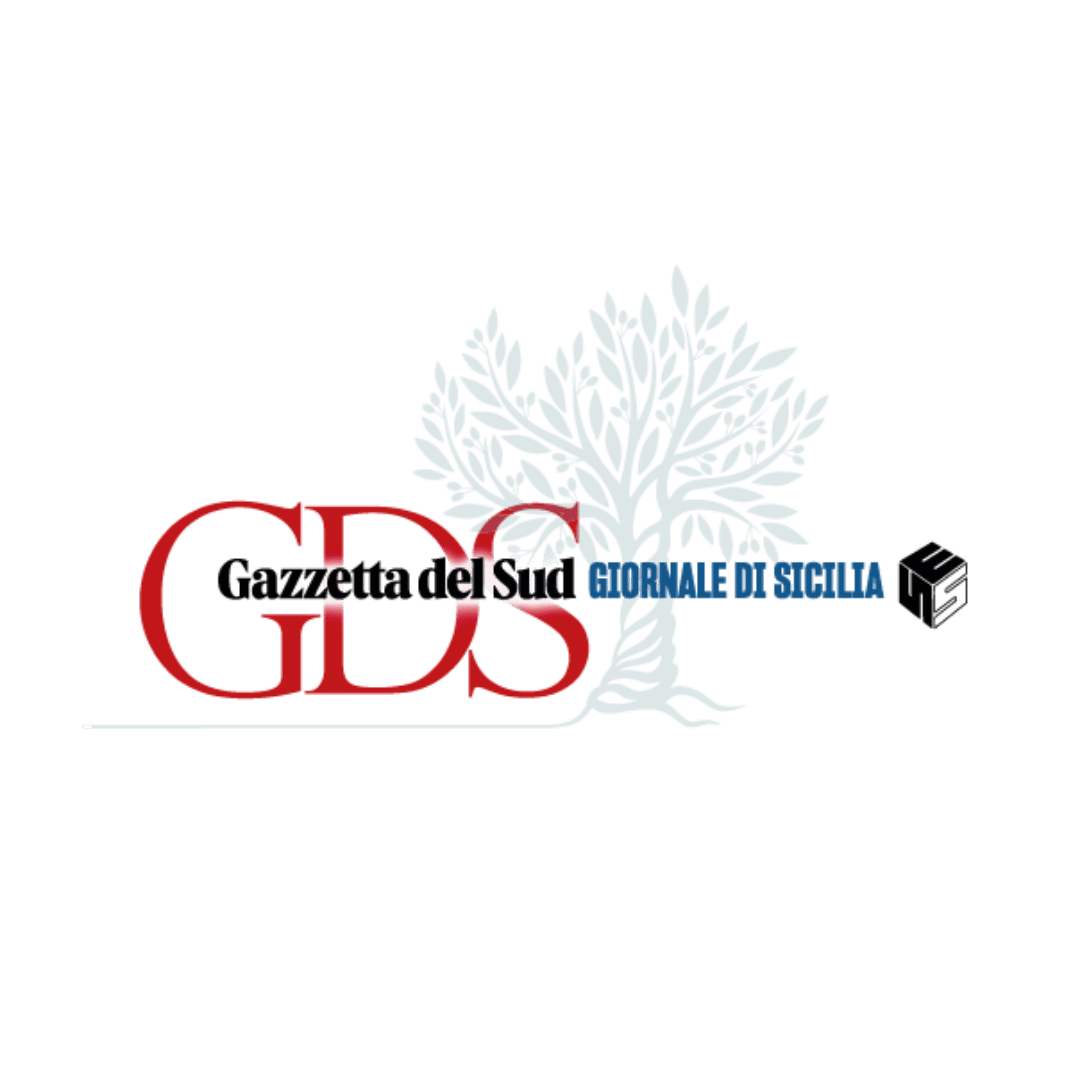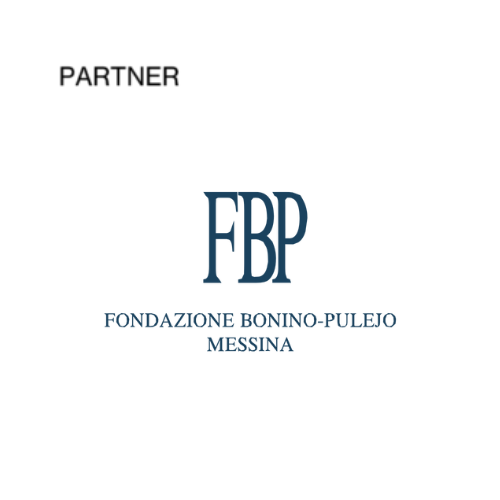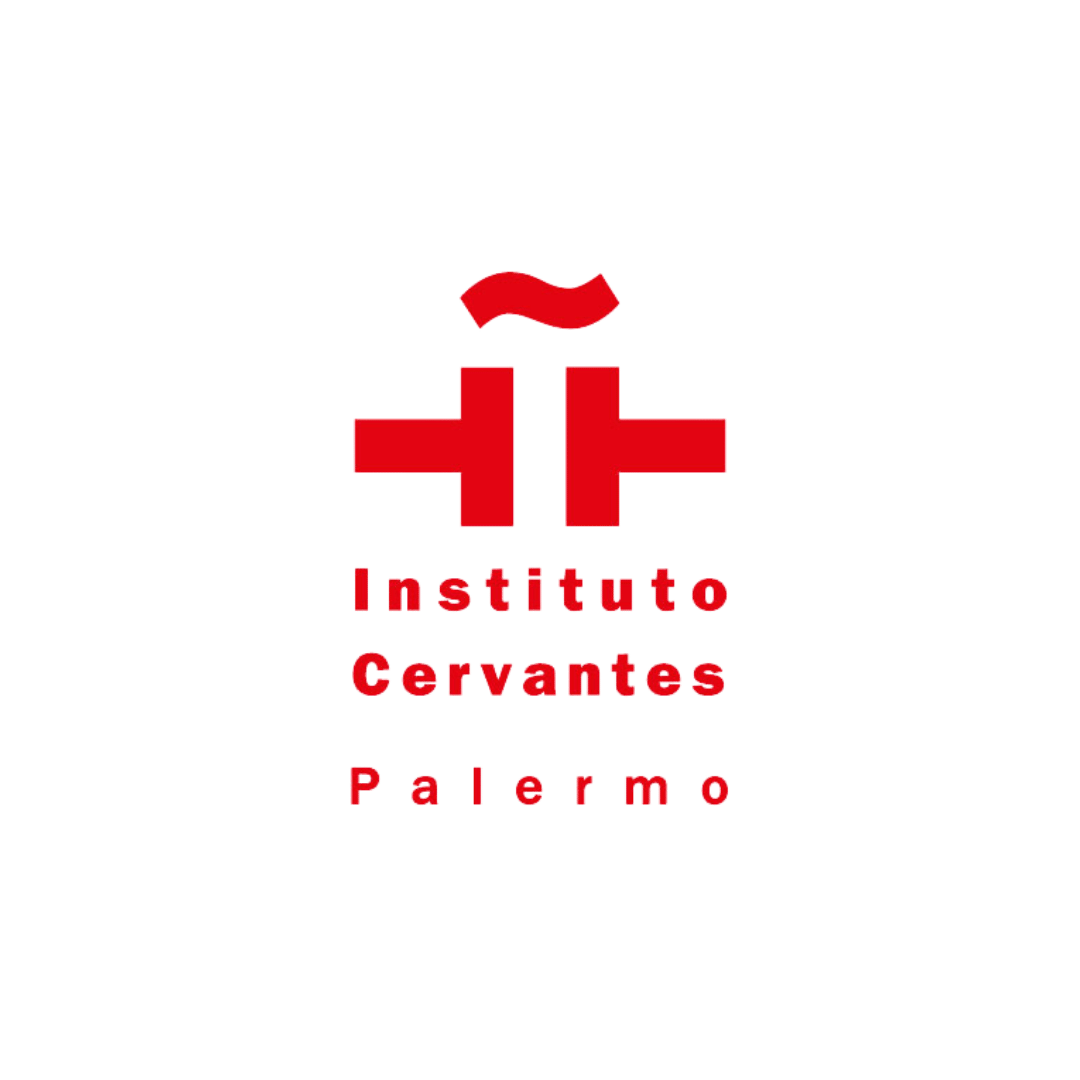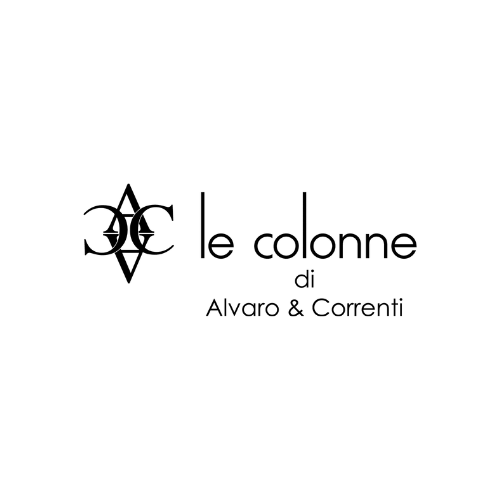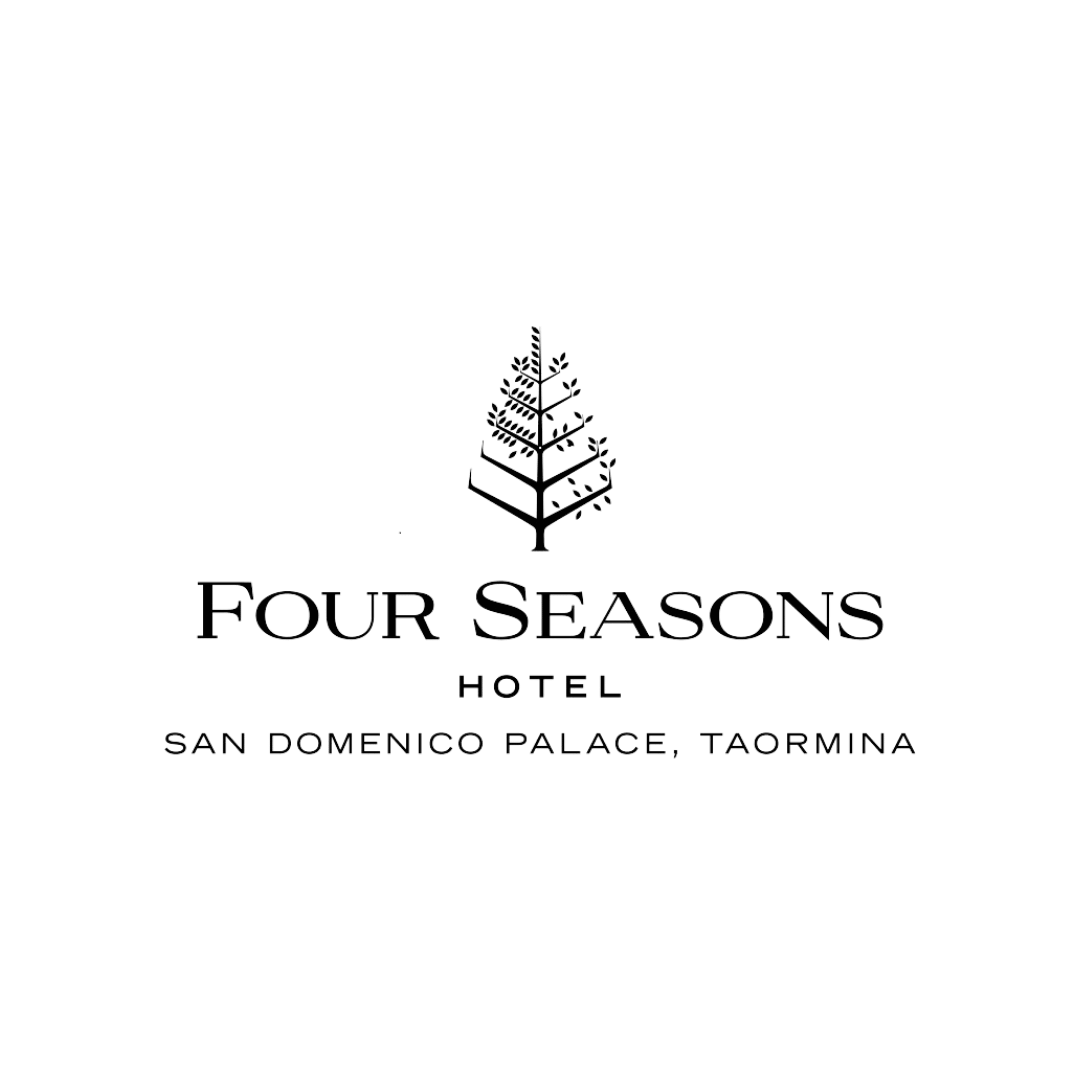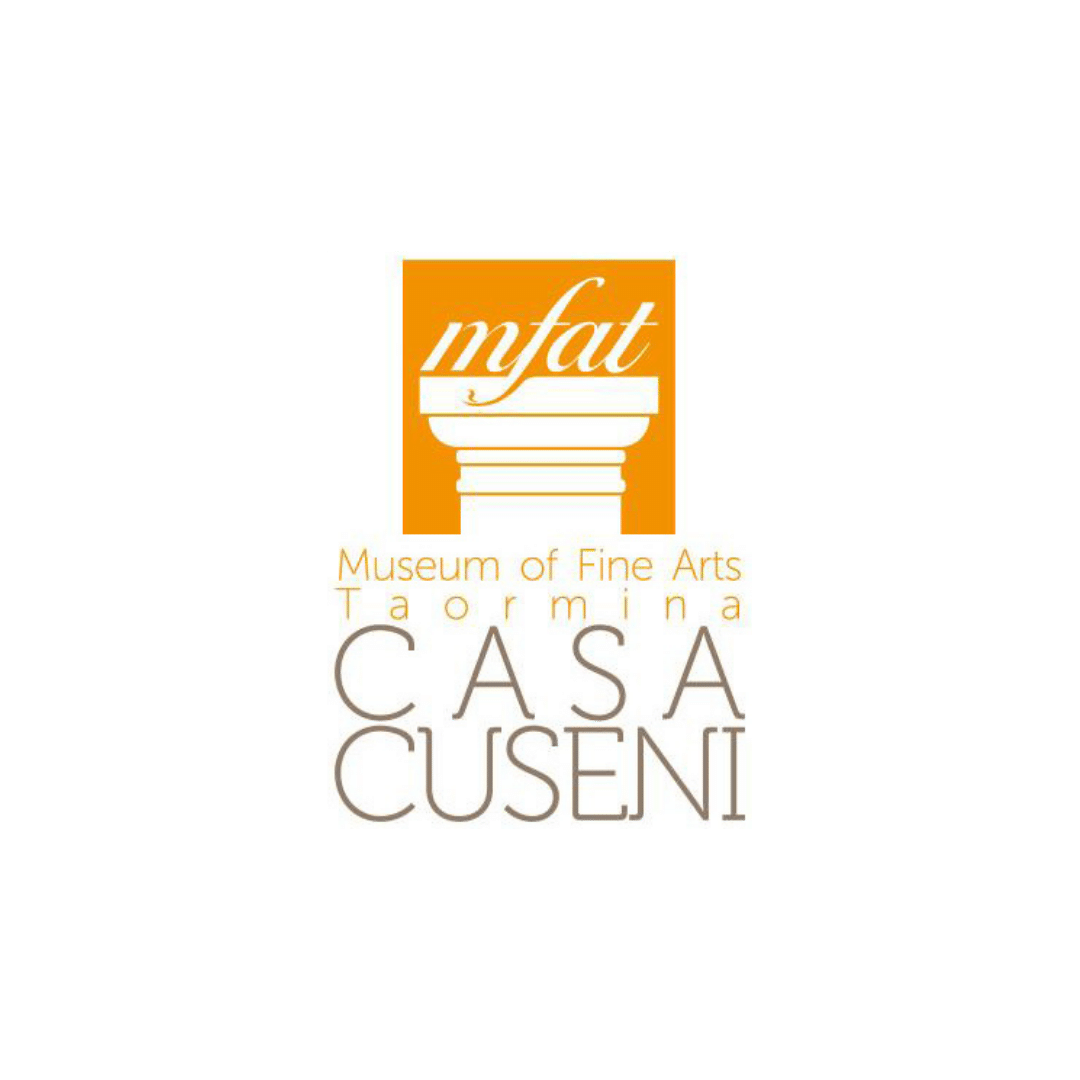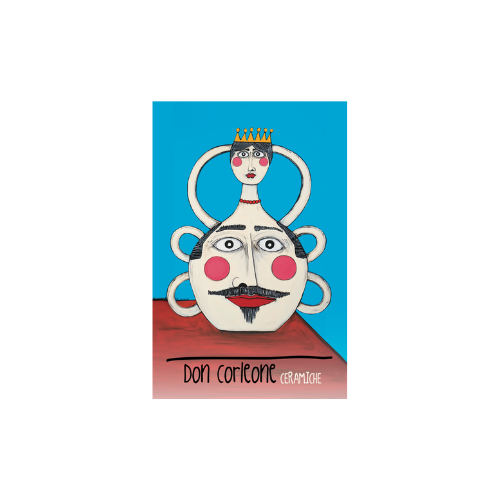In occasione dei 90 anni dell’Editrice Ave, si è svolto venerdì 17 ottobre a Palazzo Rospigliosi di Roma un incontro pubblico dedicato al tema “90 anni di parole che creano ponti: l’Editrice Ave tra passato e futuro”. Un dialogo aperto sul ruolo della comunicazione, della cultura e della fede in un tempo di profondi mutamenti, che ha riunito rappresentanti del mondo editoriale, accademico e religioso.
Dopo il saluto del presidente nazionale di Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano, hanno preso parte alla tavola rotonda Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taobuk – Taormina International Book Festival, Padre Giuseppe Riggio SJ, direttore di Aggiornamenti Sociali, e Alessandro Zaccuri, direttore della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in un confronto moderato dalla giornalista Giuseppina Paterniti.
Nel suo intervento, Antonella Ferrara ha proposto una riflessione profonda sul valore del racconto e della divulgazione come forme di ospitalità, sulla responsabilità culturale dell’editoria e sul ruolo dei festival letterari come ecosistemi di comunità. Ha richiamato l’urgenza di una “lingua ospitale” – capace di tenere insieme precisione e prossimità, tradizione e innovazione – e l’importanza di coltivare ascolto, memoria, prossimità, profezia e fragilità come parole-ponte per il futuro dell’editoria.
Ne ripercorriamo di seguito alcuni passaggi:
– Che valore oggi hanno il racconto e la divulgazione? Quale “lingua” adottare in questo tempo?
Prima di essere direttrice e ideatrice del Festival Taobuk sono stata una libraia. Ho capito una piccola ma fondamentale questione: il lettore che varca la soglia (della libreria) non sempre conosce quello che cerca. Ho capito che bisogna prima di tutto ascoltare.
Così, anche nell’organizzazione del Festival ogni scelta di programma è un atto di conciliazione tra la ricchezza dell’offerta editoriale e il bisogno di cultura – a volte inconsapevole, a volte un po’ indistinto – del pubblico.
In entrambi i luoghi ho visto che racconto e divulgazione sono forme di ospitalità. Non sono una semplificazione al ribasso: sono piuttosto la capacità di accogliere, di tenere aperta una porta, di far entrare nel testo chi forse ne sarebbe rimasto ai margini.
Viviamo in una stagione in cui l’algoritmo promette di conoscerci meglio di noi stessi, ma la vera prossimità nasce ancora da una voce che ti interpella e da un incontro che ti sorprende. La “lingua” di questo tempo, allora, credo debba essere una lingua ospitale: precisa, perché rispetta i contenuti; porosa, perché lascia passare l’esperienza; inclusiva, perché non rinuncia alla complessità ma la rende praticabile. È la lingua del libraio che consiglia senza imporre. È la lingua del festival che costruisce cornici perché dentro possano accadere cose non previste.
Vorrei soffermarmi su una questione che sento particolarmente urgente quando penso al percorso di una casa editrice come AVE: come l’editoria cattolica possa abitare questo tempo senza perdere la propria identità, ma anche senza chiudersi in una lingua che parla solo a chi già condivide tutto.
Il rischio più grande, oggi, non è tradire la tradizione, ma renderla muta. Quando parliamo di “apertura al mondo che cambia” non intendiamo un adeguamento superficiale ai linguaggi del momento, né tantomeno un’attenuazione del messaggio. Intendo invece la capacità di riconoscere che il mondo in cui ci troviamo pone domande nuove — sull’identità, sulla giustizia, sulla solitudine digitale — e che quelle domande meritano risposte che sappiano dialogare con le inquietudini reali delle persone.
L’editoria cattolica ha una ricchezza immensa: una tradizione di pensiero che attraversa secoli, una visione antropologica profonda, una rete capillare di comunità. Ma ha anche una responsabilità: non dare per scontato che questa ricchezza sia automaticamente accessibile. Serve traduzione, nel senso più nobile del termine: portare oltre, far passare. Per permettere l’incontro.
C’è poi il tema della complessità. Viviamo nell’epoca delle risposte rapide, delle polarizzazioni, delle semplificazioni. L’editoria cattolica ha gli strumenti per opporsi a questa deriva: può offrire pensiero lungo, può restituire profondità, può mostrare che le questioni decisive della vita non si risolvono con uno slogan.
Tornando indietro nel mio intervento, credo alla bellezza e all’urgenza di una lingua ospitale e che il racconto non è mai solo una forma letteraria: è un modo di abitare il mondo.
Rispetto alle modalità di comunicazione e promozione dei libri, in che modo si sono evolute nel corso degli ultimi anni le fiere e i festival dedicati all’editoria?
– Sappiamo tutti che la comunicazione e la promozione dei libri ha subito una profonda evoluzione nel corso degli ultimi anni. Vengo al cuore del tema. In questi anni ho visto le fiere e i festival passare — permettetemi la sintesi — da vetrine a ecosistemi, da annunci a narrazioni.
Ventisette anni fa lo scrittore era una figura un po’ separata, lontana, dai suoi lettori, certo c’erano le presentazioni nelle librerie delle città più importanti ma si trattava di un circuito per lettori forti, fortissimi. La lettura e la letteratura erano esperienze separate dallo spazio comunitario, ogni lettore era solo col suo libro, solo col suo autore preferito.
Oggi vediamo nei nostri festival una comunità che si riconosce nella passione per questo o quell’autore, per un genere letterario, lettori che si emozionano per il reading di un poeta, che accorrono per i ragionamenti di un intellettuale.
Da vetrine a ecosistemi.
Un tempo organizzare significava soprattutto allestire: stand, palchi, scalette, cartelle stampa. Oggi la promozione di un libro non si esaurisce nell’“esserci” di un autore: si progetta un’esperienza. Al festival non portiamo solo titoli, ma cornici narrative: percorsi tematici in formati diversi (dialoghi, masterclass, laboratori per le scuole, passeggiate letterarie), momenti professionali per gli addetti ai lavori e momenti popolari per la cittadinanza.
E in questo ecosistema si moltiplicano le occasioni di relazione tra lettori, editori, librai, bibliotecari, insegnanti: la filiera si riconosce e si rinforza.
Da annunci a narrazioni.
I programmi non si “pubblicano”: si raccontano. L’uscita del calendario non è un pdf in allegato; è una storia a puntate: anticipazioni che svelano il filo rosso, brevi video che presentano un autore con una domanda chiave, pillole audio in cui un editor spiega perché quel libro “serve”, grafiche che mappano i percorsi consigliati. Anche l’identità visiva diventa una promessa: riconoscibile, sobria, ma calda — capace di dire: “qui c’è un senso”.
Inoltre, questo lo ripeto spesso quando mi chiedono: “Ma il Taobuk è a giugno quindi a ottobre che fai?”
I festival non finiscono mai.
La comunicazione è diventata perenne: progetti nelle scuole, club di lettura, anteprime itineranti, podcast e newsletter che tengono viva la conversazione tutto l’anno. Così il pubblico non è chiamato solo “quando servono i numeri”, ma è accompagnato, ascoltato, coinvolto. Un festival, oggi, funziona quando è capace di esserci anche nei mesi in cui la città non è piena di palchi.
Dentro questa trasformazione sono emerse alcune pratiche che sento di proporre come lezioni apprese:
- Centralità della curatela. L’abbondanza non è una strategia: la cura sì. Meglio un programma con un tema forte e poche linee chiare — anche coraggiose — che un lunghissimo cartellone senza rotta. La comunicazione ringrazia: quando il senso è nitido, tutto diventa più semplice da raccontare.
- Le fiere e i festival funzionano quando si fanno città. Non calano dall’alto come astronavi comunicative, ma dialogano con i luoghi: scuole, università, teatri, biblioteche, parrocchie, librerie. Un festival diventa bene comune, non solo “appuntamento”.
- A questo proposito sono fondamentali le alleanze con chi presidia comunità reali. Oltre ai grandi media, oggi funzionano – permettetemi una parola un po’ blasfema – gli influencer di lettura: insegnanti, bibliotecari, associazioni laiche e religiose, circoli universitari, club di lettura. Non chiediamo loro solo di “condividere” un post ma co-progettiamo attività su misura. Il passaparola, quando è autentico, batte ogni campagna.
- BookToker con criterio. E newsletter editoriali. Una possibilità, vicina al punto precedente, è la collaborazione con profili social che non fotografano il libro ma lo abitano: video brevi, una domanda potente, una frase che resta. È necessaria però l’onestà: è promozione, sì, ma dev’essere credibile. Per quanto riguarda le newsletter non dovrebbero assomigliare a un bollettino di servizio un racconto di senso: link, consigli di lettura, ipotesi sulla direzione della letteratura.
Vorrei aggiungere una postilla sulla realtà del mercato editoriale.
Siamo tutti consapevoli del periodo di incertezza legato a mutamenti sociali, culturali e strettamente tecnologici. I dati recenti sono chiari: si vende meno, specialmente tra i piccoli editori, non per mancanza di qualità, ma, più spesso, per il rumore mediatico che sovrasta voci peculiari e innovative. Per il tempo sottratto dall’economia dell’attenzione. E forse anche per la fiducia messa a dura prova anche da classifiche e recensioni poco trasparenti.
Stiamo anche comprendendo che la soluzione di rispondere alla crisi moltiplicando le novità non amplia il pubblico. Piuttosto accorcia la vita dei libri e impedisce di costruire quel rapporto di fiducia essenziale con i lettori.
Che c’entrano fiere e festival? Tutto. Se l’iper-offerta schiaccia, noi dobbiamo fare l’esatto contrario: rallentare e selezionare. Mettere in programma adozioni consapevoli di catalogo, creare percorsi per generi e fasce d’età che aiutino a scegliere, dedicare spazi stabili ai libri per ragazzi e ai loro mediatori naturali (insegnanti, bibliotecari, educatori). E poi presidiare la fiducia: regole chiare sulla trasparenza delle segnalazioni, mediazione competente e punti di vendita con poche proposte motivate. Meno fuochi d’artificio e più eredità.
In questo modo la promozione torna ad essere promessa mantenuta: non una lotteria in cui le case editrici sperano di pescare il numero giusto per salvare i conti annuali. So benissimo che i responsabili della casa editrice Ave troveranno un po’ ridondante questo passo, dato il loro percorso di costruzione paziente di comunità, ma mi perdoneranno se credo che sia sempre necessario ricordare la premessa etica del nostro lavoro.
Un altro rischio dei Festival è la cosiddetta eventificazione.
I grandi nomi attraggono, e noi a Taormina lo sappiamo bene.
Negli anni abbiamo ospitato spesso premi Nobel. Ma proprio questa esperienza mi ha insegnato che la reputazione è un faro, non il porto. Funziona quando illumina una rotta: metti un Nobel in dialogo con un giovane esordiente, con un ricercatore che ha i piedi nel presente, con un tema che interroga l’oggi. Diversamente il grande nome rischia di diventare evento senza eredità. La promozione, se è solo “effetto wow”, evapora; se invece innesta curiosità e relazione, sedimenta.
C’è il rischio che la macchina della promozione divori il contenuto. L’eventificazione trasforma il libro in pretesto per una foto, il pensiero in slogan, la complessità in gadget.
Come reagire? A volte credo ci sia bisogno di ritmo e silenzio. Non tutto dev’essere ripreso. Ci sono momenti che chiedono concentrazione: lo dichiariamo, spegniamo le camere, lasciamo spazio al pensiero. Poi possiamo restituire con cura estratti editoriali. Sicuramente c’è bisogno di formati che favoriscono la profondità: domande preparate, tempi certi e un moderatore competente.
Ho scelto tre parole-ponte che guidano la comunicazione dei festival e delle fiere:
- Ospitalità. Accogliere non significa dire tutto a tutti, ma spiegare bene a chi e perché. Un festival “aperto” non è un festival indistinto: è un festival leggibile.
- Leggerezza, nel senso di Calvino: togliere peso senza togliere profondità. Un titolo chiaro, una spiegazione che orienta, un’infografica che fa scegliere. La leggerezza è una forma di rispetto per il tempo degli altri.
- Coraggio. Dare spazio a voci periferiche, a editori indipendenti, a generi ibridi. Raccontarli con la stessa dignità narrativa che si riserva ai “big”. Il pubblico sente quando un invito nasce da una necessità culturale e non da un calcolo.
Ogni festival coltiva il proprio pubblico, ogni festival è una risorsa in un paese come il nostro, sempre caratterizzato dai tanti campanili. Così come in questi anni abbiamo assistito e salutato la crescita della piccola e media editoria, così dobbiamo considerare la proliferazione dei festival, fattore di allargamento e pluralità dell’editoria italiana, della cultura e della lettura.
– Quali parole e posture valorizzare per continuare a creare ponti tra passato e prospettive future?
Se dovessi indicare alcune parole-chiave per questo compito di costruzione di ponti, ne sceglierei alcune che sento decisive:
Ascolto. Non l’ascolto tattico di chi cerca di capire “cosa funziona”, ma l’ascolto genuino di chi riconosce nell’altro un interlocutore, non un target. L’editoria cattolica ha una lunga tradizione di accompagnamento spirituale: è una forma di ascolto profondo, che non giudica, che sta con la persona nel suo cammino. Ecco, quell’ascolto può diventare un modello editoriale. Ascoltare cosa chiedono i lettori, cosa cercano, dove faticano. Ascoltare anche i silenzi, le assenze: chi non legge più, e perché.
Memoria. Non come nostalgia, ma come radice. Il passato non è un museo da difendere, è un patrimonio da far fruttare. L’editoria cattolica custodisce testi, pensieri, esperienze che hanno attraversato epoche e culture. Questo è un tesoro da rendere vivo. Penso a riedizioni curate con intelligenza, che non si limitino a riproporre ma che contestualizzino, che mostrino perché quel testo parla ancora oggi. Penso a collane che mettano in dialogo autori del passato con questioni contemporanee.
Prossimità. È forse la parola più evangelica, e anche la più attuale. In un tempo in cui la distanza si è fatta norma — distanza dai corpi, dalle relazioni, dalla realtà — parlare di prossimità significa proporre un’alternativa antropologica. L’editoria può praticare prossimità in molti modi: pubblicando storie di vita reale, dando voce a chi è ai margini, creando spazi fisici e digitali dove le persone si ritrovano intorno a un libro.
Profezia. Uso questa parola con cautela, ma credo sia necessaria. Profezia non nel senso di predire il futuro, ma nel senso biblico di dire una parola che interpella, che chiama in causa, che non si accontenta dello status quo. L’editoria cattolica ha il compito — e il diritto — di essere controcorrente quando è necessario. Di pubblicare testi che non assecondano il mercato ma lo interrogano. Di dare spazio a visioni che non sono maggioritarie ma sono necessarie.
Fragilità. Può sembrare strano includere questa parola, ma credo che sia una delle più importanti. Il nostro tempo chiede di dare dignità alla fragilità, al dubbio, alla ricerca. Pubblicare testi che non temono di mostrare il cammino, e non solo l’arrivo. Raccontare testimonianze che includono la fatica, e non solo il trionfo. Questo non indebolisce il messaggio: lo rende umano, credibile, fraterno.
Quanto alla postura, credo che l’editoria cattolica debba coltivare una duplice attitudine: Fermezza nei valori, apertura nelle forme. Saper dire “questo è il nostro orizzonte” senza chiudere la porta a chi sta cercando una strada. Saper proporre senza prevaricazione. Saper testimoniare senza giudicare.
Per concludere, mi piace pensare che anche un festival — e una casa editrice che festeggia 90 anni — sia un ponte. Da una parte c’è la ricerca e la scrittura; dall’altra c’è la vita delle persone. In mezzo ci siamo noi: librai, editori, comunicatori, curatori, insegnanti, lettori. Il nostro compito è garantire la tenuta, indicare la direzione e — ogni tanto — fermarci a guardare il paesaggio.
E per l’editoria cattolica, questo ponte ha un significato ancora più profondo: è il luogo dove una tradizione millenaria incontra le domande di oggi, dove la memoria è generativa. Novant’anni non sono un traguardo: sono una promessa che si rinnova, pagina dopo pagina, lettore dopo lettore, ponte dopo ponte.
Se c’è una postura da valorizzare, è quella del pontefice culturale – colui o colei che sa tenere insieme mondi diversi, che non cede alla semplificazione, ma coltiva la complessità. Ma la parola da sola, l’abbiamo detto, non basta. Serve una postura etica: rispetto, reciprocità, capacità di rinunciare al protagonismo sterile. In questo, la lezione dell’editoria cattolica – quando è fedele alla sua vocazione culturale e pastorale – è ancora attuale: l’umiltà della parola che serve, non che impone.
L’augurio che mi permetto di condividere è che AVE continui ad essere editore di ponti, non solo di libri. Che sappia narrare la fede nella storia, attraverso strumenti nuovi ma con lo stesso spirito: lo spirito del dialogo e del servizio. Se cultura, fede e società devono tornare a parlarsi – come AVE fa da novant’anni – allora servono piattaforme coraggiose, visioni alte, e parole che restano. È in questa direzione che possiamo costruire, insieme, un futuro editoriale e culturale capace di lasciare traccia. Grazie infine per avermi invitata a condividere questa riflessione. E buon compleanno, AVE: che i tuoi 90 anni siano un esempio per tutti.